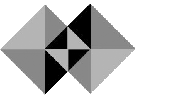|
L’accidia è la voce dotta di pigrizia, un termine diffuso
dalla Chiesa, che ne fece un vizio capitale perché non solo
considerato peccato di negligenza, ma negligenza
nell'esercizio della virtù.
Il suo nome viene dal greco akédia, che significa
noncuranza.
L'accidia è un horror vacui, un grande vuoto, una voragine
che attira.
L’accidia è sinonimo di pigrizia e viceversa.
Come altri vizi genera un piacere temporaneo.
Per gli antichi, che dell'ozio avevano un grande rispetto,
non era una colpa, ma semplicemente un modo di essere come
un altro.
E dunque la pigrizia non sarebbe poi gran male se secoli di
morale cattolica non ci avessero insegnato a considerare
questo atteggiamento un vizio capitale.
La sola preoccupazione dell'accidioso è quella di non
muoversi e di non muovere, di lasciare le cose come stanno,
tanto non c'è nulla per cui valga la pena di agire e
impegnarsi.
Accidia e fatalismo vanno spesso a braccetto.
Dante colloca gli accidiosi: a sprofondare nella palude
Stigia.
L’accidia non è un vizio a sé, come l'ira o la gola, ma un
peccato di omissione. L’omissione del praticare il bene,
anche là dove sarebbe possibile con poco sforzo.
I precettori di un tempo si accanivano contro l'accidia
poiché, da moralisti, la consideravano l'anticamera della
lussuria.
Ma anche rinunciando a voler identificare l'ozio con il
vizio, non c'è dubbio che è l'intelligenza ad essere la più
mortificata dalla pratica della pigrizia.
L’intelligenza, assopita, si ripiega su se stessa
La vitalità si compiace unicamente di non venire spesa.
L'accidia chiede dedizione: è un abbraccio mortale.
Vi sono vizi che sono vie di perfezione, mezzi di
conoscenza.
Ma l'accidia porta a un nulla narcisistico, alla
contemplazione della propria inutilità.
Qualcuno obietta che, essendo l'uomo costretto continuamente
a scegliere, il non agire sembra essere l'ultimo rifugio
della saggezza, un modo di non sbagliare, in definitiva di
salvarsi.
Per questo, forse, essa è un'inclinazione così naturale nei
giovani, ai quali le prospettive del vivere sembrano,
specialmente oggi, più indecifrabili che mai.
E sarebbe una giustificazione legittima se non rimanesse il
dubbio che una tale inazione non sia dettata dalla coscienza
della complessità dei problemi, quanto dalla riluttanza ad
affrontarli, da una neghittosità del carattere che sembra
comune a un'intera generazione.
E certo, se l'accidia discende dal temperamento, è anche
vero che essa è incentivata dal benessere delle famiglie.
È vero. Ecco l'alibi culturale: l'atarassia, la suprema
indifferenza di fronte alle passioni. In realtà, la pigrizia
elevata a sistema filosofia. Perché correre, perché
agitarsi, quando tutto è perituro, e comunque precario?
Allora provo a mettermi dall'altra parte, e a chiedermi se
per caso, in un mondo che arranca trafelato, in una società
dominata dal mito della competizione, non sia per caso
l'inerzia una virtù.
Scegliere di non intervenire non è un atto tra i più
ignobili, eppure ripugna alla coscienza abituata da sempre a
porsi dei traguardi più o meno nobili.
|
Se osserviamo il passato troviamo che sempre sono
esistiti movimenti collettivi di astensione. Sette di ogni
genere hanno cercato di dare alla pigrizia una legittimità
ideologica.
Quella dei « figli dei fiori », tanto per citare quella più
cara ai giovani, mantiene ancora oggi, dopo qualche
decennio, un suo fascino. Ogni volta c'è, all'origine, una
ventata di rivolta, un desiderio di opposizione, una volontà
combattiva di trasgressione, che si trasforma poi in
vittimismo.
E così quell'ebrezza, quella romantica ribellione sfocia,
oggi come allora, nella droga, nella fuga dalla realtà,
nell'autodistruzione.
L'uso di massa della droga, ecco l'accidia della nostra
epoca.
Vale a dire una specie di infezione maligna, un cancro
dell'anima i cui effetti sono invisibili ma operano in
profondità.
Quella beatitudine di cui sembra di essere padroni si
trasforma insensibilmente in tirannia.
Giorno dopo giorno una sorta di torpore condiziona la
volontà.
Ogni proposito è messo in dubbio, ogni decisione rimandata.
E chi non sa assumersi il minimo impegno, non realizza
alcunché.
Infingardo, aggettivo in disuso, continua a valere per colui
che si abbandona al proprio nulla, al trascorrere ozioso del
tempo che non diventa tuttavia meditazione sul tempo o sulla
storia ma semplice vegetare.
L'accidioso è spesso taciturno, forse perché sono
sconosciute a lui stesso le ragioni di tanta inerzia. Perché
prima di essere fisica la pigrizia è mentale, è uno stato
insondabile di abbandono, una incapacità a uscire dal
guscio, una vocazione al letargo.
Il pigro rinuncia a competere alla gara che sa di non poter
comunque vincere, e dunque per orgoglio, cerca degli alibi
alla sua passività, o, come si suol dire, razionalizza.
C'è da domandarsi che cosa faccia da supporto a questo
stato, e che ruolo vi abbia la presunzione piuttosto che la
disistima di sé.
Se cioè certi momenti di accidia non siano dettati dal
timore che, agendo, si possa essere comunque disillusi e
quindi costretti a prendere coscienza di deficienze
insospettate.
Chiudersi, abdicare, giacere in una poltrona ascoltando il
pulsare quieto del corpo è meno stressante e rischioso che
proporsi un qualsiasi obiettivo.
Ma l'accidia non è soltanto il rimanere immobili. Si può
correre e nello stesso tempo non desiderare alcun
cambiamento, nessuna novità, niente che alteri il ritmo
sperimentato dell'abitudine.
Si può apparire disinvolti e simpatici e poi non possedere
neppure un filo di disponibilità a spendersi per una persona
o per una causa.
Si può essere egoisti, in tutti c'è una certa dose di
egoismo.
Ma l'accidia oltrepassa la soglia dell'egoismo: essa è
chiusura assoluta, ritrattazione di ciò che accade intorno,
partecipazione negata.
Eppure mi fa essere tollerante verso questo vizio un vago
complesso di colpa: quello di sapere che forse il mio
affannarmi e competere e lottare, il mio desiderio di
affermazione e conquista non è così limpido come si
vorrebbe, ma inquinato di quella ferocia che la pigrizia
almeno non conosce.
Alla pratica dell'accidia occorre molto narcisismo. Una
capacità infinita di autoassoluzione. Simile al desiderio di
libertà essa sa inventare pretesti innumerevoli, chiede
spazi, dilazioni, comprensioni da tutti.
E si finisce di stancare tutti, anche le persone più care.
|